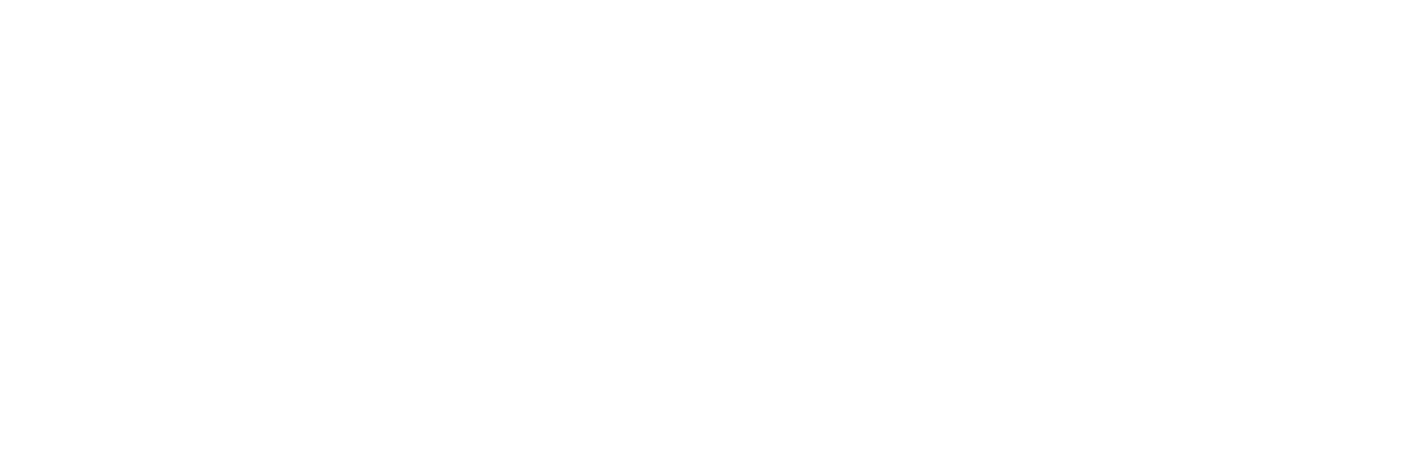Natale festa di famiglia: lo conferma il detto «Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi». Regali, Babbi Natale, centri commerciali presi d’assalto, luci, addobbi, presepi, solidarietà, auguri, vacanze, neve (almeno in qualche parte del mondo, e finché dura, visti i rapidi e drammatici cambiamenti climatici)… e ancora falò, concerti, tavole imbandite, panettoni e cinepanettoni; se poi si infila di mezzo anche una messa, tanto meglio… Troppe cose diverse mescolate? Sì, è vero, un servizio di culto non è sullo stesso piano delle palle di neve e un concreto gesto di solidarietà non va accostato a uno sdolcinato film natalizio. Ma è proprio questo che avviene a Natale. Il garbuglio è inestricabile sin dalla sua genesi.
Basta infatti consultare un’enciclopedia Per avere la conferma che il Natale è nato – chiediamo venia per il gioco di parole – nel IV secolo, allorché a una festa pagana nel tardo Impero romano si sovrappose la decisione di celebrare la nascita di Cristo (di cui peraltro – come ribadiremo – ignoriamo giorno, mese e anno: evidentemente i redattori dei quattro Vangeli ritenevano irrilevanti, ai fini della fede, questi dati anagrafici). Al pari di altri casi di contaminazione fra cristianesimo (ma forse è meglio dire cattolicesimo) e paganesimo, anche questa festa incontrò il favore popolare, un favore testimoniato nel corso dei secoli dall’apporto di suggestive celebrazioni e usanze di provenienza varia (romana, anatolica, germanica, anglosassone…). E circa il presepe, per inciso, esso risale al Medioevo e inscena anche cose inesatte (nessuno, ad esempio, sa quanti fossero i Magi, e non risulta che Gesù bambino fosse circondato da animali né che fosse in una grotta…).
Che il Natale risalga al IV sec. d.C., per “cristianizzare” l’antica festività pagana del Dies natalis solis invicti (25 dicembre) è dunque risaputo. Tanto i quattro Vangeli canonici, quanto l’intero Nuovo Testamento, non fanno alcun cenno all’osservanza, da parte dei cristiani, di un giorno di “compleanno” di Gesù. Neppure altri documenti storici ci aiutano a conoscere giorno e anno della Natività, la quale – anche se la cosa può sembrare paradossale – va collocata in un tempo imprecisato fra il 7 e il 4… a.C.: la datazione del monaco Dionigi il Piccolo – V-VI secolo d.C. – è stata infatti opportunamente rivista dagli studiosi, basandosi sui pochi dati certi a disposizione (ad esempio il fatto che Erode – quello della strage degli innocenti, per intenderci – morì nel 4 a.C.): Cristo è nato prima del fantomatico “anno zero” e, oltretutto, gli unici dati che abbiamo depongono non a favore di una data invernale, bensì di una compresa fra la primavera e l’estate.
Natale significa “che riguarda la nascita”. Nel nostro caso, la nascita di Gesù di Nazareth. Se è lui che si vuole festeggiare, allora andrebbe anche rispettato, e il modo migliore per farlo è attenersi ai documenti che hanno comunicato al mondo quel che di lui sappiamo, ossia ciò che è stato testimoniato dai suoi primi discepoli e dagli scrittori sacri del Nuovo Testamento (apostoli, altri testimoni della primissima ora e discepoli comunque collegati agli apostoli). L’enfasi dei Vangeli (Matteo, Marco, Luca e Giovanni), delle lettere apostoliche (di Paolo, di Pietro…) e dell’Apocalisse di Giovanni è posta sempre e solo sulla necessità di comprendere chi è Gesù Cristo, di credere in lui e di vivere secondo i suoi insegnamenti: è questo che deve fare un vero discepolo.
Gesù è nato per portare la più alta rivelazione di Dio e per far sì che chiunque possa conoscere il Padre e avere la vita eterna. Ma lo stesso Gesù richiede una sequela continua, consapevole, impegnativa: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua» (Luca 9, 23 – e sorge spontanea la domanda: non sarà che “Gesù bambino” lo preferiamo perché non ci dice cose di questo tipo?). Vangelo significa “buona notizia”, e la buona notizia è: «Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete al Vangelo» (Marco 1, 15). Ma la si dà concretamente questa notizia, a Natale? Nel migliore dei casi solo qua e là, soffocata e dispersa fra mille altre cose. E perciò ininfluente.
Ragioniamo, dunque: per diffondere un generale (ma più spesso generico e passeggero) sentimento di fratellanza e bontà, di cui peraltro gli uomini sono sempre stati capaci quando lo hanno voluto, non serviva certo che Gesù nascesse, predicasse, desse il suo esempio, facesse miracoli, morisse sulla croce, risuscitasse e ascendesse al cielo… Perciò è opportuno ribadire che il Natale è una festa di fatto pagana (usiamo il termine senza alcun tono spregiativo) e che sarebbe più corretto, se la vogliamo mantenere, darle un nuovo nome: per i romani era il Dies natalis solis invicti, noi potremmo sceglierne un altro, lasciando da parte gli aspetti cristiani, che in realtà – come spiegato – di veramente cristiano hanno poco o nulla. Il Natale è un impasto di sacro, profano e pagano, lo è sempre stato: l’adiacenza, accertata dal IV secolo d.C., con il 25 dicembre della festività pagana del “Dies natalis solis invicti”, ne fu già un primo indicatore.
E i cristiani? Hanno una festa i cristiani secondo il Nuovo Testamento? Sì, per chi la vuole celebrare: cristiano significa “seguace di Cristo”, e non si tratta di un impegno di qualche giorno all’anno! Il “Natale” dei cristiani è una festa – e al tempo stesso una fatica – quotidiana. E la sua stessa vita, giorno per giorno, a fianco del Signore, per protendersi verso la vita eterna (Giovanni 11:26).
Che ne direbbe dunque del Natale Gesù di Nazaret? Ebbene, Gesù è venuto per alcune ragioni specifiche: invitarci al pentimento (“Ravvedetevi e credete al Vangelo”, disse: Marco 1:15); essere l’Agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo (Giovanni 1:29 – ma quanti si preoccupano ancora del peccato, termine quasi obsoleto?); indicarci la verità, la vita eterna, la via per giungere al Padre; insegnarci che le tradizioni umane non sono Parola di Dio e che diventare suoi discepoli significa entrare da una “porta stretta” (Matteo 7:13, 15:6.9); morire sulla croce, risorgere, salire al cielo e tornare per giudicare il mondo. Dovremmo chiederci, allora, se Cristo – che il Nuovo Testamento rivela quale Dio entrato da uomo nella Storia umana – al posto di una festa che non ha mai richiesto, non desideri molto, molto di più: vale a dire che ciascuno di noi, uscendo da una folla anonima e confusa, inizi a conoscerlo veramente, per diventare suo discepolo. Perché cristiani non si nasce, ma si diventa. Dividiamo la Storia in a.C. e d.C.: se sarà così anche per la nostra storia personale – e ciò significherebbe una nuova nascita, interiore – allora avremo davvero il nostro vero Natale. Ogni giorno.
Valerio Marchi