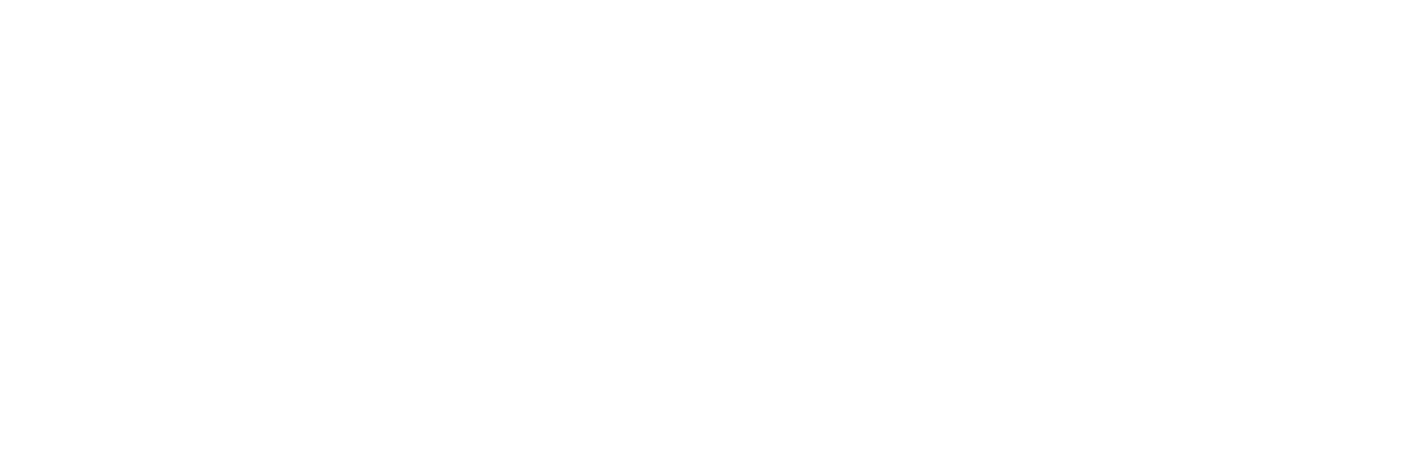Subito dopo la divulgazione di alcune immagini catturate dal James Webb Space Telescope (un favoloso strumento che ci proietta – e ci proietterà ancora – ben oltre i limiti di spazio e di tempo cui siamo abituati) si è inaugurata la 23ª Esposizione Internazionale di Triennale Milano, aperta fino al 11 dicembre 2022. Il tema – Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries – riguarda i misteri del mondo conosciuto e apre uno spazio di riflessione su «ciò che non sappiamo di non sapere»: un omaggio, dunque, alla parte sconosciuta dell’universo micro e macro che ci spaventa e ci attrae allo stesso tempo. In circostanze simili mi sovvengono sempre le riflessioni, più che mai attuali, del grande scienziato e pensatore francese del Seicento Blaise Pascal, che fra l’altro conobbe a un certo punto della sua esistenza una decisa svolta religiosa, avvicinandosi alla Bibbia e approfondendo giorno per giorno il suo legame con il Signore Gesù.
Dove ci portano le conoscenze sulla natura, nel cui seno il nostro pianeta «è solo un punto impercettibile»? Da un lato, nota Pascal, noi esseri umani siamo in grado di «gonfiare le nostre concezioni al di là degli spazi immaginabili»; dall’altro, tuttavia, più conosciamo e più sappiamo di non conoscere il Tutto: infatti, «che cos’è mai un uomo nell’Infinito?». Inoltre, ciò che vale per l’infinitamente grande concerne anche l’infinitamente piccolo, che a sua volta apre «un’infinità di universi». È inevitabile, allora, che l’uomo si senta «sgomento di se stesso» e «sospeso tra i due abissi», un essere «di mezzo tra il tutto e il nulla, e infinitamente lontano dalla comprensione di questi estremi»: per tutti noi, insomma, «il termine delle cose e il loro principio restano invincibilmente celati in un segreto imperscrutabile».
La realtà è questa: «Siamo qualche cosa e non siamo tutto», perciò vaghiamo «in un vasto mare, sospinti da un estremo all’altro, sempre incerti e fluttuanti», bramosi di «trovare un assetto stabile» proprio mentre «ogni nostro fondamento scricchiola». E allora, vedendoci «sperduti in questo remoto angolo dell’universo», dovremmo imparare «a stimare al giusto valore la terra, i reami, le città e noi stessi»; e dovremmo per prima cosa addentrarci in noi stessi: «Se l’uomo cominciasse con lo studiare se stesso, capirebbe quant’è incapace di spingersi oltre» e, ammettendo «di essere miserabile», potrebbe aspirare alla vera «grandezza», quella morale.
In effetti – continua Pascal – tutta la nostra infelicità, con le agitazioni, le liti, le passioni sconsiderate, i pericoli e le pene a cui ci esponiamo, deriva «da una sola causa: non saper restare tranquilli in una camera». Ci slanciamo verso imprese che tempo addietro neppure la fantascienza avrebbe potuto immaginare e ciò, di per sé, non è un male; lo diventa, tuttavia, se nel frattempo rimaniamo rispetto a noi stessi dei «mostri incomprensibili» e non facciamo abbastanza per porre rimedio alla cruda e paradossale verità: «Com’è vuoto il cuore dell’uomo, e pieno di lordure!».
Nel canto XXVI dell’Inferno di Dante leggiamo: «Fatti non foste a viver come bruti / ma per seguir virtute e canoscenza» (è la conclusione del discorso con il quale Ulisse sprona i suoi compagni a proseguire oltre le colonne d’Ercole). La propensione alla conoscenza e al progresso fa parte della nostra natura; tuttavia – riflettiamo – che ne è dell’avanzamento nella virtù e della crescita del nostro spirito? Già, perché mentre la scienza e la tecnologia ci fanno oltrepassare confini che un tempo potevamo solo sognare, qui, nell’infinitesimale ma preziosissimo granello assegnatoci nel Cosmo, ci martoriamo senza fine, facendoci in molti modi la guerra e devastando la nostra stessa casa.
«Sapere è potere»: così proclamò, nello stesso secolo di Pascal, il filosofo e politico inglese Francis Bacon, che concepì un ambizioso progetto di rinnovamento della ricerca scientifica. Non aveva torto, ma ovviamente non poteva prevedere che un giorno, proprio a causa del nostro potere mal gestito, avremmo potuto autodistruggerci. Il nostro sguardo si estende a dismisura ma, a quanto pare, siamo terribilmente presbiti: infatti sul nostro pianeta, come osservava Pascal, «corriamo spensierati verso il precipizio, dopo esserci messi dinanzi agli occhi qualcosa che c’impedisca di vederlo». E, soprattutto, non siamo capaci di emettere un realistico giudizio su noi stessi: «Invano, o uomini, cercate il rimedio alle vostre miserie in voi stessi» – scriveva ancora Pascal –, aggiungendo: «Senza Gesù Cristo, l’uomo è di necessità nel vizio e nella miseria; con Gesù Cristo, è esente da vizio e da miseria. In Cristo è tutta la nostra virtù e tutta la nostra felicità; senza di lui non c’è se non vizio, miseria, errori, tenebra, morte, disperazione».
Nessun macchinario umano, per quanto incredibilmente sofisticato, ci farà mai vedere Dio e ci indicherà la direzione giusta verso l’Infinito. Gesù, invece, ci dice: «Io sono la via, la verità e la vita, nessuno va al Padre se non per mezzo di me… Chi vede me, vede il Padre» (Vangelo di Giovanni 14:6.9). Solo Gesù, come ha scritto l’apostolo Paolo, può condurci nella nostra «abitazione celeste», un’«abitazione non fatta da mano d’uomo, eterna, nei cieli» (2ª Lettera ai Corinzi 5:1-2) che nessun telescopio potrà mai vedere, perché si vede solo con gli occhi della fede.
Valerio Marchi